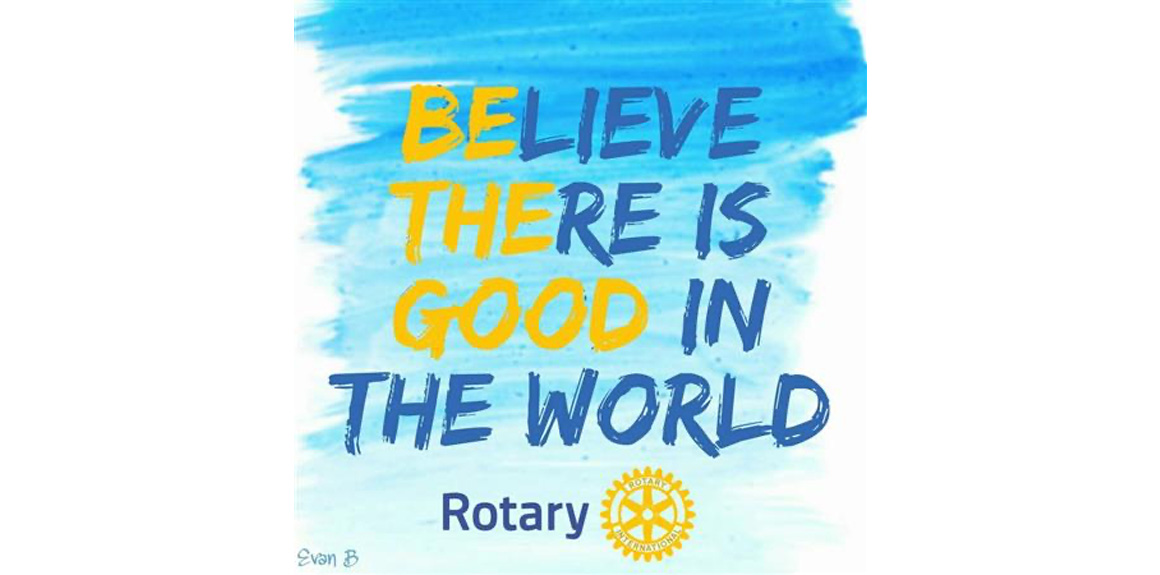L’etica, (dal greco antico “ethos”, carattere, comportamento, costume), è quella branca della filosofia che studia i fondamenti oggettivi e razionali che permettono di distinguerli in buoni, giusti o moralmente leciti, rispetto ai comportamenti ritenuti cattivi o moralmente inappropriati.
La morale, (dal latino “mos-moris”, costume, usanza, oppure legge, regola, norma) rappresenta la condotta diretta da norme, la guida secondo la quale l’uomo agisce e diventa un valore suscettibile di valutazione e di giudizio.
La deontologia (dal greco “deon”=dovere) è l’insieme delle regole comportamentali: nel caso di una professione, il cosiddetto “codice etico”si riferisce alle norme comportamentali di una determinata categoria professionale.
Fatta questa indispensabile premessa, necessaria per inquadrare il concetto di etica e rapportarlo alla storia e all’inserimento del Rotary nella società, vediamo, in breve, come è nato e come si è sviluppato.
Quando nacque a Chicago, nel 1905, il Rotary era definito come un club di uomini d’affari con quattro scopi principali:
1) subordinazione di ogni attività all’utilità sociale;
2) osservanza della più alta moralità professionale;
3) sviluppo della conoscenza reciproca per un migliore servizio sociale;
4) progresso della cultura, della comprensione, dell’armonia sociale attraverso scambi intellettuali e cognizione delle reciproche sfere di attività. In questo primo sviluppo del Rotary, manca, nella definizione, ”a fianco degli uomini d’affari”, il termine “professionisti”, e, nei quattro punti, l’amicizia e l’aiuto reciproco. Tra il 1905 e il 1911 nascono negli USA tanti altri club rotariani basati sull’assistenza reciproca e su tanti servizi sociali. Entra così nella definizione del Rotary (1911) il termine servire (SERVICE) con le sue implicazioni e il suo significato. La definizione viene così modificata in “organizzazione di uomini d’affari e di professionisti al servizio degli altri”.
Nel corso degli anni vengono proposti numerosi e diversi Codici Etici che a volte creano situazioni di crisi con altre istituzioni come nel 1928 con la Chiesa di Roma.
In realtà il principale Codice Etico rotariano di cui disponiamo, e che tuttora funziona in modo eccellente, è la prova delle quattro domande; nel 1932 Herbert G.Taylor, propose questo test di verifica del buon rotariano. La prova fu adottata dal R.I. Nel 1943.
Ecco le quattro domande:
ciò che penso, dico, faccio…
1) risponde a verità?
2) è giusto per tutti gli interessati?
3) creerà migliori rapporti di amicizia?
4) è vantaggioso per tutti gli interessati?.
Dalla risposta a queste quattro domande, l’etica, nella sua complessità di interpretazione e valutazione, diventa una realtà semplice e concreta, perchè l’etica nasce dai rotariani e si concretizza con le loro azioni. L’etica, così, diventa un punto centrale nella vita del Rotary, perchè ha lo scopo di cooptare persone per fare “service”, nel senso di azione utile alla comunità.
Il concetto di “elitarietà” dei rotariani va inteso nel senso di cooptare persone che eccellono nella loro professione e che quindi possono essere di esempio ad altri professionisti nell’ambito della loro attività. Questa comunione di intenti crea un rapporto di amicizia che si “esalta” nell’interesse comune del “fare” per il conseguimento degli ideali rotariani, il Rotary diventa così un esempio di etica concreta ed attiva: catena imitativa che deve orientare sia i subalterni sia gli interlocutori professionali: essi devono sentirsi “spiazzati”dalla applicazione di regole morali intese ad evitare conflitti speculativi ed orientata ad essere di esempio per una sana concorrenza, che lascia spazio vitale a tutti gli altri interpreti, meno dotati, di una società sempre più giungla.
L’etica professionale così intesa, è solo un’azione morale tesa a creare una coscienza sociale, a dare dignità all’uomo per farlo sentire partecipe del prorio sviluppo e non succube di un Moloch, dove l’unica dottrina è quella del Dio profitto.
Questi comportamenti sono difficili da applicare nella vita quotidiana, perchè comportano un continuo controllo del proprio istinto alla lotta per la sopravvivenza. E’ un modello di vita che si trova in molte religioni, specie in quella cristiana: “cercare di fare agli altri quello che noi vorremmo fosse fatto a noi”, questo enunciato basterebbe da solo ad unire questa religione con il Buddismo (in particolare) e associarla all’etica del Rotary, ma mentre la religione cristiana, con i suoi straordinari insegnamenti (le sette opere di misericordia corporale e le sette opere di misericordia spirituale), ha un fine salvifico e trascendentale, l’etica rotariana nasce e si applica per quel senso morale che sta dentro di noi e che ci fa sentire fratelli dell’Umanità, a prescindere dal significato escatologico della nostra esistenza.
Pasquale Simonelli